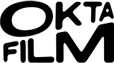Proseguiamo le “Prove d’ascolto” di Okta Film con un’intervista storica, realizzata presso gli Studi Televisivi dell’Università di Firenze nell’anno 1998 per la serie “Archivio della scrittura delle donne in Toscana dal 1861 ad oggi”, a cura di Liana Borghi, Maria Teresa Caciagli Fancelli, Ernestina Pellegrini (Dipartimento di Filologia Moderna).
Disponibile in lingua originale su Youtube, questa conversazione tra bell hooks e Maria Nadotti non era mai stata sottotitolata in italiano. Ci tenevamo dunque a renderla accessibile anche nella nostra lingua e ci piace movimentare questa nostra serie scompaginando le temporalità che definiscono il passato in base al trascorrere lineare del tempo. Nelle parole di bell c’è tutto il nostro a venire.
A corredo della videointervista, alcuni materiali utili a situare bell hooks, le sue opere e il suo pensiero nel tessuto culturale e politico italiano e nel suo farsi.
bell come la madre, Rosa Bell Watkins. hooks come la nonna materna, Bell Blair Hooks. Minuscole, in entrambi i casi, le iniziali.
Lo pseudonimo “militante” che negli anni ’70 va a sostituire il nome anagrafico di Gloria Jean Watkins ha infatti una triplice funzione: affermare con forza la valenza politica di un atto di ri-nominazione che è gesto fondativo di una soggettività inedita; ancorare quel nuovo sé femminista, battezzato con nomi materni, a un continuum femminile che solo ora, alla luce di una pratica politica collettiva che sa dirsi tale, può riscattarsi da una silenziosa, secolare, apparente passività; sfidare il “proprietario” — e per le donne “espropriativo” — sistema dei nomi, che lungo l’asse maschile incensa non contraddittoriamente individualità e continuità, negandole entrambe lungo quello femminile.

Scrivere al buio
di Maria Nadotti
bell hooks (1952-2021), un’afroamericana dalle origini di classe molto umili, nata nel Sud rurale e segregato degli Stati Uniti, arriva al femminismo che è poco più che una ragazzina. Ha lasciato da poco la casa dei genitori e, grazie a una borsa di studio, è approdata all’Università di Stanford, California.
Il campus, in quegli anni, è attraversato da una forte ondata libertaria: gli studenti sono in lotta contro la guerra del Vietnam, i neri militano nelle file del Black Power Party e delle Black Panther, le donne hanno cominciato a separarsi dalle organizzazioni politiche della sinistra per dar vita ai primi collettivi femministi e ai primi gruppi di autocoscienza.
Per bell/Gloria, che è cresciuta a Hopkinsville, Kentucky, dove vige un sistema di apartheid totale, si tratta di un’iniziazione politica intensa e fulminea. Nella sua città natale l’incommensurabilità della distanza che separa, anche spazialmente, il mondo dei neri dal mondo dei bianchi è marcata dai binari della ferrovia.
A valicarli, in un pendolarismo dalla regolamentazione feroce, sono soltanto i neri, che di giorno vanno a lavorare e servire nella città bianca e di notte sono obbligati a tornare al loro posto, senza lasciare traccia di sé.
Lì, in quella comunità separata, in una famiglia di sette figli — sei femmine e un maschio — governata da un padre dispotico e violento, si vanno gettando le basi della complessa e radicale analisi teorica e politica che ben presto farà di bell una delle figure di intellettuale più innovative e popolari degli Stati Uniti.
I termini dell’oppressione che sperimenta, bambina e poi adolescente, portano infatti il duplice segno della discriminazione razziale e dell’autoritarismo paterno.
La dissennatezza di un sistema sociale che segrega ed esclude i neri, “leggendo” nel colore della loro pelle il segno di un’inferiorità che altro non è se non il frutto di un rapporto di potere e di una neppur troppo travestita ingegneria delle diseguaglianze, si riverbera, tra le mura domestiche, nell’ingiustificata asimmetria tra ruolo paterno e ruolo materno, tra parola maschile e silenzio femminile.
La famiglia è la palestra in cui bell/Gloria si attrezza a decifrare i messaggi compositi e solo all’apparenza contraddittori del sistema integrato che più tardi, attraverso un sintagma addensato ai limiti dell’implosione, definirà “patriarcato capitalista suprematista bianco”.
Il nodo da sciogliere è infatti la coniugazione infernale di razzismo e sessismo, senza isolarli l’uno dall’altro e senza immaginare che li si possa combattere separatamente e in tempi successivi, quasi che l’uno non fosse la faccia stravolta del secondo e non fossero entrambi espressione di un’unica, onnipresente strategia del dominio e dell’abuso.
Quando, appena diciassettenne, partecipando ai primi Women’s Studies apertisi a Stanford, bell si accorge che la parola/concetto “donna” che lì si pratica rischia di non contenerla, di esporla a una nuova invisibilità, la sua reazione politica è immediata.
Invece di ritirarsi e di sparire nella militanza più ovvia, quella che la vorrebbe al fianco dei suoi fratelli di razza, sceglie di rischiare con e tra le donne la sfida di una pratica femminista che riconosca le differenze senza eliderle o gerarchizzarle. All’identità indifferenziata, “di casta”, del primo femminismo statunitense, che ipotizza un’essenza femminile, un essere originario delle donne, prevalente sulle variabili di razza e di classe, bell contrappone un’analisi più audace e spregiudicata, meno ideologica e più realista.
La soggettività femminista, come scrive in Ain’t I a Woman: Black Women and Feminism, una raccolta di saggi prodotti tra il 1972 e il 1973 e però pubblicati solo nel 1981, comporta una precisa presa di coscienza delle tante e mai definitive identità e appartenenze di ciascuna.
Nella stessa tensione omologante che vorrebbe fare di ogni donna l’alleata naturale di ogni altra donna c’è — afferma già allora bell — un vizio logico o concettuale.
Non solo le donne non sono uguali tra loro, ma appiattirle a quell’unico comune denominatore che a esse verrebbe dal condividere il giogo sessista, significa letteralmente ridurle al silenzio, cancellarle, teorizzarle piuttosto che conoscerle. Il sessismo, che pure è strumento obiettivo della loro oppressione, non postula infatti per le donne, per tutte le donne, soltanto la posizione di vittime e non le riguarda esclusivamente in quanto oggetti del dominio maschile.
Per decifrare le complicità, le collusioni, le identificazioni che hanno finito per macchiare e incrostare di sessismo anche il “femminile”, è indispensabile non trascurare quegli altri livelli di individuazione personale che passano dall’appartenenza razziale e dalla collocazione di classe.
La specificità di ogni donna, vale a dire il terreno esperienziale su cui ciascuna può fondare l’invenzione del proprio mutamento sta — ed è questa la vera scoperta metodologica del femminismo caro a bell hooks — nella sua biografia e nella sua cognizione di sé come parte di un mondo non statico, complesso, mai banalmente binario.
La presa di coscienza del soggetto femminil/femminista passa dunque da un’autoanalisi serrata e dal confronto non imperioso né dogmatico con altre donne che abbiano avviato Io stesso processo di autotrasformazione o — per usare un termine caro a hooks — di conversione.
In ogni donna — suggerisce più volte la scrittrice — c’è una frizione tra due o più identità apparentemente incompatibili eppure conviventi.
La soluzione non sta nell’assumerne una a scapito delle altre tentando l’avventura della non contraddizione, bensì nel praticare la virtù acrobatica del non coincidere mai sino in fondo con una posizione monodimensionale e unitaria. “Più di ogni altra cosa,” racconta non a caso bell, “ho desiderato essere una scrittrice, ma anche un’accademica.
Se questi due desideri in conflitto mi hanno creato tensione e ansia, l’aspirazione a scrivere mi ha permesso però di ribellarmi allo status quo dell’accademia.”
La contraddizione o l’apparente inconciliabilità diventano allora leva forte per la scoperta, per la ricerca di una non accomodante e imprevista mossa a Iato. Per hooks il risultato di questa “eccessività” o “eccedenza” è l’assunzione di una posizione poco consueta, se non eccentrica, rispetto al panorama intellettuale statunitense e ai suoi perimetri.
Troppo militante e compromessa da un lato con la politica delle donne e dall’altro con quella degli afroamericani, troppo trasversale e in-disciplinata, troppo appassionata alla grande questione della democrazia e della “comunicazione” extra-istituzionale, hooks ha scelto di non esaurire la sua funzione pedagogica in ambito universitario.
La tematica che per lei “richiede il massimo della nostra attenzione è quella della rappresentazione”. Sessismo e razzismo, i due sistemi che convogliano l’odio contro l’alterità incarnata da donne e non-bianchi, hanno infatti un loro subdolo terreno di applicazione a tutto campo proprio nelle cosiddette — più o meno commerciali — produzioni culturali: cinema, letteratura, musica popolare, cronache giornalistiche, moda, pubblicità, televisione.
Ecco perché, alla sua prolifica attività di teorica e critica, hooks affianca — dentro e fuori le aule scolastiche — una vivace e versatile attività di commentatrice culturale.
“Nella nostra cultura troppo lavoro intellettuale non si rivolge alle persone reali là dove esse sono, anche se è proprio da lì che bisognerebbe invece partire. E spesso il luogo dove gli individui più immediatamente sono è lo spazio della loro vita, del loro stesso corpo, delle loro aspirazioni e dei loro sogni.”
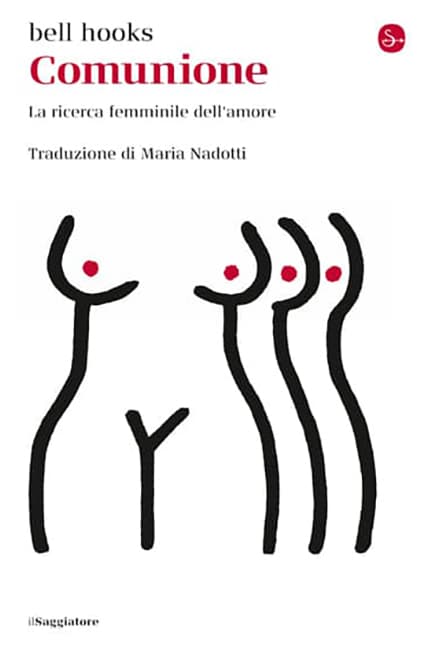

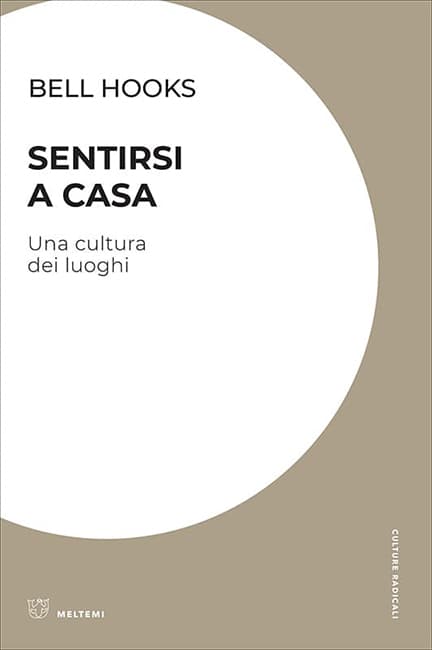
BIBLIOGRAFIA
Per situare i testi entro la cornice del loro transatlantico farsi, indichiamo anche il titolo, l’editore e l’anno della prima edizione statunitense di ciascun volume.
bell hooks, Elogio del margine. Razza, sesso e mercato culturale, cura e trad. it. di Maria Nadotti, Feltrinelli, Milano 1998. Questa antologia di scritti hooksiani è stata creata dalla curatrice e traduttrice con il benestare di bell hooks e non ha dunque un proprio equivalente americano.
Maria Nadotti, Scrivere al buio. Maria Nadotti intervista bell hooks, la Tartaruga, Milano 1998.
bell hooks, All About Love: New Visions, William Morrow & Co, New York, NY 2000; Maria Nadotti (a cura di), Tutto sull’amore. Nuove visioni, trad. it. di Lucia Cornalba, Feltrinelli, Milano 2000.
bell hooks/Maria Nadotti, Elogio del margine/Scrivere al buio, nuova edizione congiunta, Tamu Edizioni, Napoli 2020.
bell hooks, Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom, Routledge, London and New York, NY 1994; Insegnare a trasgredire. L’educazione come pratica della libertà, trad. it. di Feminoska, Meltemi Editore, Milano 2020.
bell hooks, Feminism Is for Everybody: Passionate Politics, South End Press, Boston 2000; Il femminismo è per tutti. Una politica appassionata, trad. it. di Maria Nadotti, Tamu Edizioni, Napoli 2021.
bell hooks, Teaching Community: A Pedagogy of Hope, Routledge, London and New York, NY. 2003; Insegnare comunità. Una pedagogia della speranza, trad. it. di Feminoska, Meltemi Editore, Milano 2022.
bell hooks, The Will to Change: Men, Masculinity, and Love, Washington Square Press, NYC 2004; La volontà di cambiare. Mascolinità e amore, trad. it. di Bruna Tortotella, il Saggiatore, Milano 2022.
bell hooks, All About Love: New Visions, William Morrow & Co, New York, NY 2000; Tutto sull’amore. Nuove visioni, nuova edizione a cura di Maria Nadotti, il Saggiatore, Milano 2022.
bell hooks, Where We Stand: Class Matters, Routledge, London and New York, NY 2000; Da che parte stiamo. La classe conta, trad. it. di Marie Moïse, Tamu Edizioni, Napoli 2022.
bell hooks, Teaching Critical Thinking: Practical Wisdom, Routledge, London and New York, NY 2010; Insegnare il pensiero critico. Saggezza pratica, trad. it. di Feminoska, Meltemi Editore, Milano 2023.
bell hooks, Communion: The Female Search for Love, William Morrow, an imprint of HarperCollins Publishers, New York, NY 2002; Comunione. La ricerca femminile dell’amore, trad. it. di Maria Nadotti, il Saggiatore, Milano 2023.
bell hooks, Ain’t I a Woman?Black Women and Feminism, South End Press, Boston 1981; Non sono una donna, io: Donne nere e femminismo, trad. it. di Federica Fugazzotto, Tamu Edizioni, Napoli 2023.
bell hooks, Belonging: A Culture of Place, Routledge, New York, NY 2008; Sentirsi a casa.Una cultura dei luoghi, trad. it. di Feminoska, Meltemi Editore, Milano 2023.